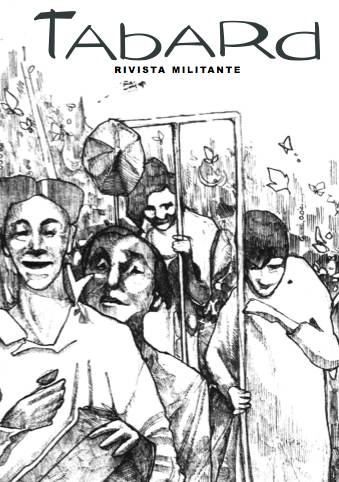Temo che si tratti di un altro pezzo sulla critica letteraria, di Christian Raimo

Il discorso sulla malasorte, la decadenza, se non l’agonia, la putrefazione della critica letteraria è diventato un genere a sé. I critici italiani (gli intellettuali, i teorici, i professori universitari…) lo praticano sempre più spesso, e – va riconosciuto – con grande maestria. Le grida di allarmi, i tentativi di risvegliare il cadavere si susseguono. Carla Benedetti qualche anno fa parlava di tradimento dei critici; Mario Lavagetto di eutanasia della critica; Gabriele Pedullà un paio di mesi fa sulle pagine di Alias inaugurava – con un articolo intitolato “Se la critica muore” – quello che è stato un dibattito che è proseguito sul manifesto, si è seminato sulle terze pagine degli altri giornali, sui siti letterari in rete, tra i convegni di coloro che con lo studio della letteratura ci campano; ah, e da ultimo è uscito in questi giorni da Meltemi L’altra critica di Raul Mordenti. Così un lettore forte, un individuo critico con l’industria culturale del proprio tempo e del proprio paese, non può fingere di non sapere quale sia il pessimo stato di salute della critica letteraria oggi in Italia. Dove per “critica letteraria” si deve intendere un’importante sineddoche della militanza culturale, dell’impegno politico che ognuno deve mettere nell’agire lo spazio pubblico.
Diagnosticato il male però, la questione senza soluzioni di contrasto incisive si ripropone identica, o peggiore. La critica muore, si può vegliarla. Amen. Nessuno però dei critici che abbiamo sopra citato è un apocalittico, anzi. Da una parte: ognuno cerca di analizzare il fenomeno a partire da alcune trasformazioni strutturali del campo della cultura in Italia. Il berlusconismo in primis, si è concordi, il berlusconismo in tutte le sue forme (comprese le versioni più suadenti della sinistra) ha finito col devastare – antropologicamente – una nazioncina già debilitata da decenni di abusi di potere, fascismi striscianti, ideologie del consumo invasive. Mordenti si rifà a Steiner e ne conia quasi una formula: dove c’era la critica oggi c’è la pubblicità. Ma la stessa dinamica di malpensiero la denuncia chi addita D’Orrico, piazzista di libri sul Corriere Magazine, o chi – come Pedullà – fa notare che l’atteggiamento di stizza rispetto a un contradditorio è lo stesso per Berlusconi, quando lascia sdegnato lo studio dell’Annunziata, e per Baricco, quando si lamenta in prima pagina su Repubblica del malanimo dei recensori nei suoi confronti.
E appunto, dall’altra parte, però: ognuno non si lascia affascinare dal proprio cahiér de doleance, ma abbozza soluzioni. Bibliodiversità, creazione di aree di autonomia dell’esercizio della critica fuori dalle macchine editoriali, boicottaggio, riqualificazione di quegli agenti culturali ormai resi cadaveri anche loro: la scuola, l’università, l’editoria indipendente.
Non ci sarebbe nulla da aggiungere. Se non che: l’impressione che rimane è quella di un’ultima battaglia tipo Termopili. Piccoli atti di resistenza contro un’avanzata micidiale e incontrastabile. Ma è veramente così?
Facciamo un passo altrove. Nel 1901 Bertrand Russell formulava uno dei paradossi più celebri della storia del pensiero. Il paradosso del barbiere. Un villaggio ha tra i suoi abitanti uno ed un solo barbiere, uomo ben sbarbato. Sull’insegna del suo negozio è scritto Il barbiere rade tutti – e unicamente – coloro che non si radono da soli. La domanda a questo punto è: chi rade il barbiere? La risposta che uno è naturalmente portato a dare è “il barbiere si rade da solo”. Ma in questo modo viola una premessa: il barbiere rasandosi non raderebbe unicamente coloro che non si radono da soli. Allora viene spontaneo il pensare che il barbiere sarà raso da qualcun altro, ma ancora una volta si viola una premessa: che il barbiere rade tutti coloro che non si radono da soli (per dirla in altre parole, il barbiere se si rade da solo non dovrebbe radersi, se non si rade da solo dovrebbe radersi). Eppure il barbiere è ben sbarbato… Il paradosso all’inizio del Novecento ebbe un effetto domino su tutta la disciplina della logica formale. E Russell lo riscrisse per la teoria degli insiemi così: un insieme può essere o meno elemento di se stesso?
Ora, questa è la formula che mi viene in mente da applicare quando mi trovo di fronte a un discorso sulle difficoltà della critica pronunciato da un critico. Può un critico, con gli strumenti linguistici, concettuali che si è formato nel pieno del Novecento, nel momento in cui l’esistenza, il valore della critica non faceva problema, riuscire a sbrogliare questo paradosso mortale in cui lui stesso è avvinto?
Ma facciamo un passo indietro, perché a questo deficit se ne aggiunge un altro, collegato. Di fronte a un incontestabile declino del ruolo dell’intellettuale, di fronte al suo deprimente discredito, il nemico che si indica, la causa del male è il dominio della comunicazione televisiva e del marketing. Questa calamità ogni volta è invocata come se si trattasse di un mostro proteiforme e incarpibile. Perché? Perché i critici della cultura non studiano forme e modi di indagine dell’universo televisivo e di quello pubblicitario in modo da non lanciarsi semplicemente in invettive liquidatorie sulla decadenza intellettuale dell’italiano medio? Perché non è stato scritto in Italia un libro come quello di Steven Johnson, Tutto quello che ti fa male ti fa bene (Mondadori, 2006), che segnala l’evoluzione incredibile che le forme della narrazione hanno avuto negli ultimi trent’anni grazie ai telefilm e ai videogiochi, e la conseguente trasformazione delle competenze cognitive delle giovani generazioni? La televisione è veramente questa creatura orribile che plasma in modo ottundente le menti, rendendole semplici recettrici di messaggi promozionali? Capito il punto? È veramente tutto perduto o sta lì lì per esalare l’ultimo respiro?
Cosa deve fare allora un critico? Non avere paura. Non temere lo strapotere del mercato. Rinnovare il proprio bagaglio novecentesco composto di “avanguardia”, “tradizione”, “sperimentazione linguistica”, etc… Staccarsi dalla bombola dell’ossigeno del proprio rinoscimento accademico (ma qualcuno di voi legge mai le riviste dei contemporaneisti delle università italiane? Sembrano che vivano isolati dal nostro pianeta surriscaldato, dentro in una specie di bolla, tra le pagine di Fahrenheit 451). Rendersi conto di essere impigliato nel modo più stretto al paradosso di Russell e agire come Alessandro di fronte al nodo di Gordio. Spezzare. Liberarsi. La critica sta morendo per una infame gestione delle risorse culturali in Italia? Invece di lasciarsi andare a geremiadi, denunciare. Ma prima di tutto, se stessi. Esporsi. Dichiarare i propri piccoli eccessi di potere. Non cercare una scialuppa, ma lottare modello Achab contro la balena del disastro universitario (orrenda metafora, ok). Mostrare quei compromessi che in ogni ambiente dove si esercita una professione culturale si è costretti ad accettare, ma soprattutto a riproporre: il berlusconismo che è in noi. Ammettere il proprio ritardo di comprensione, ribilanciare la propria esibizione di disinteresse rispetto a quegli agenti formativi come la fiction televisiva, il mondo della pubblicità, i best-seller, la televisione generalista-e-non che hanno trovato, a scapito certo anche dei dibattiti culturali e dell’elitarismo delle terze pagine, la propria legittimazione. Rendersi credibili. Cercare famelicamente la vivacità di nuove discipline: il “decennio d’oro” – come lo chiama Mordenti -, quello tra il 1962 e il 1972 fu un periodo d’oro dal punto di vista intellettuale in Italia perché finalmente si creavano prospettive multidisciplinari, il discorso filosofico si intrecciava con quello semiotico, con la psicanalisi, con l’antropologia. E oggi: quali sono i campi di studio che ci servono per tracciare nuovi paradigmi, nuovi dispositivi interpretativi?
Etichette: Rassegna Stanca
Leggi tutto il post