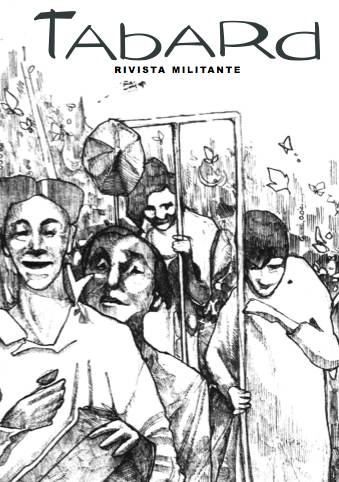Creative Jammin' Festival e FarePoesia
L'Associazione culturale O.M.P. - Officina Multimediale Pavese promuove la quarta edizione del Creative Jammin' Festival.
Il Festival si svolgerà a Pavia, presso i Giardini Malaspina, piazza Petrarca,
in data 3, 4 e 5 luglio 2008.
Ogni serata avrà inizio alle ore 19.30 con un aperitivo accompagnato da diverse performance, per proseguire alle 21.00 con l'inizio dei concerti previsti.
3 luglio 2008
concerti: "The Pentothals" e "Small Peppers"
4 luglio 2008
piccolo coro multietnico – Le Voci della Pace
concerti: "Mandolin' Brothers" e "Corte dei Miracoli"
5 luglio 2008
letture con accompagnamento musicale di testi pubblicati da Edizioni
O.M.P. - FarePoesia, Improponibili e Menestrelli di Jorvik
concerti: "Figli di Madre Ignota" e "Masked Marvel"
*****
Inoltre si promuove la presentazione degli ultimi volumi
pubblicati dalle Edizioni O.M.P. FarePoesia
Le presentazioni avranno luogo presso la libreria "Il Delfino", piazza della Vittoria 11,
alle ore 18.30, secondo il seguente calendario:
giovedì 26 giugno 2008 Stefano Barco presenta il volume "Poesia d'amuro" del Gruppo H5N1
mercoledì 2 luglio 2008 Alfonso M. Petrosino presenta il volume "Assalti poetici" di Tito Truglia
giovedì 17 luglio 2008 Federico Francucci presenta il volume "Latitudini" di Pierluigi Lanfranchi
Etichette: Annunciazziò Annunciazziò
Leggi tutto il post