Alcuni appunti di lavoro, riflettendo sul saggio di WM1 sul NIE
 Non si può evitare di misurarsi con la questione dell’epica. Forse il modo più corretto di iniziare ad analizzarla è il punto di vista adottato dal testo comparso su buonipresagi:
Non si può evitare di misurarsi con la questione dell’epica. Forse il modo più corretto di iniziare ad analizzarla è il punto di vista adottato dal testo comparso su buonipresagi:«l’autore “neo-epico” agisce in un certo senso come i cantori dell’antichità: racconta versioni personali di storie note, le modifica, le integra con altre informazioni, le adatta al pubblico che ha di fronte. Stiamo sedimentando una storia d’Italia alternativa dalle opere, per esempio, di Saviano, Sarasso, di Genna, di De Cataldo? Io credo di sì».
Il riferimento all’epica tira in ballo una serie di problemi che sembrano molto attuali per l’analisi di questi romanzi. Innanzitutto, una nuova epica intesa come rinnovata fiducia nello schema eroe-destino, nuova presa sulla realtà, fiducia nella possibilità che una narrazione “mitopoietica” ispiri l’azione non deve mai dimenticare che la propria dimensione dovrebbe essere soltanto allegorica e non simbolica.
Il riferimento di WM1 all’allegorico in questo senso, manca proprio di un'opposizione al simbolico. L’idea (eh, anche questa benjaminiana) di affondare le mani nel continuum, farne saltare determinati momenti, determinate figure, per creare nel passato un’immagine della storia “differente”, che conservi la possibilità di un’alternativa e di un riscatto, può funzionare solamente se ci si mantiene in una dimensione allegorica, e non basta qui la distinzione dall’allegoria a chiave. La nuova immagine storica non dovrebbe cioè creare un riferimento simbolico unitario, anche se questo viene pensato come libertario e antagonista. Venendo alla pratica dei romanzi, laddove la narrazione si lasci imbrigliare nella convenzionalità dello schema eroe-destino, ovvero si privi della auto-consapevolezza della costruzione, e si abbandoni senz’altro agli stilemi dell’“avventuroso”, inevitabilmente la “storia” che si voleva salvare dal continuum ed opporre ad esso, ne diviene retoricamente parte, ornamento (“ornamenti dell’oscurità…”).
In altri termini, destituita della propria “ricerca”, ridotta a “mezzo”, la scrittura non aggredisce il reale, ma si limita a restituire quell’immagine della realtà che sta prima di essa nella mente dell’autore. Non “fa” il mito. Lo trasmette. La differenza è notevole. Per questo, tradurre il “fare poetico” di Aristotele semplicemente con “fare” è un bel rischio.
È un pericolo, una narrazione che rientri nel NIE dovrebbe tenerlo presente, perché è facile cadervi, o rimuovere il problema. Resistervi richiede un assoluto controllo della narrazione, una volontà di non indulgere mai, di non lasciarsi prendere la mano. Ad esempio, mentre un romanzo come Manituana riesce a non cadervi, controllando e indirizzando struttura, tematiche e linguaggio verso una criticità “vigile” (questa parola nel senso in cui la usava WM1 a proposito della ricezione del mito), un romanzo come l’ultimo di Carlotto (Cristiani di Allah), ne rappresenta il cedimento strutturale. Ovvero un abbandono a tutte quelle tendenze narrative narcotiche e autoindulgenti che spingono a fallire in pieno qualsiasi opera di costruzione di una immagine “storica” alternativa.
Un altro di questi “pericoli” potrebbe essere indicato nel recupero della pienezza del soggetto. La storia del romanzo è la storia della dissoluzione dell’io. Certo, l’esistenza paradossale dell’io quando esso stesso è già finito è una delle caratteristiche del romanzo postmoderno. Il problema è che se si pretende di recuperare questo io in quanto io-epico, il rischio (di cui hanno parlato anche Magini-Santoni nel loro intervento su Carmilla) è di neutralizzarlo nella sua complessità e trovarsi di fronte alla psicologia di necessità convenzionale pur nell’ “eroe scaduto a personaggio” (laddove “personaggio” non ha il significato critico di individualità immersa nel caos a-morale della contraddizione, ma di carattere disegnato e rispecchiante esattamente l’idea che un autore ha di esso, quando invece il rapporto tra autore e personaggio non può che essere “demonico”). Cosicché il vecchio Lukács (dalle mani grondanti di sangue – secondo qualcuno, addirittura) che si vorrebbe buttar fuori a calci dalla porta, rientra agile agile dalla finestra nelle vesti del giovane un po’ dandy e introverso dei suoi primi e misconosciuti scritti, affermando con sorriso romantico che “eroe e destino devono rimanere”.
Un po’ di tempo fa avevo scritto di una paradossale “epicità” del romanzo postmoderno, giacché l’epica stessa può essere considerata come qualcosa di contraddittoriamente instabile, caduco, transitorio di per sé. Essa dovrebbe infatti essere una manifestazione di unità tra essenza ed esistenza, un’immanenza del senso a se stesso, in cui l’io dell’eroe è espressione dell’io unitario dell’autore, dell’epoca, di un popolo, cui fa da referente una concezione del mondo definita, chiara, e “vicina” come le stelle del bel cielo della Grecia. Ma la narrazione epica, nel momento stesso in cui si immerge nel tempo, si narra, si incomincia, rinuncia a questo stato di unità ed entra nel mondo della contraddizione. La dimensione della sua esistenza è il luogo privilegiato dell’equilibrio tra queste due condizioni. Il romanzo contemporaneo si trova in una situazione simile, perché esaurito il percorso di disfacimento dell’individualità, giunto alla massima estraneità e lontananza tra personaggio, autore ed eticità, lascia coincidere la dimensione della sua esistenza con questo trovarsi in equilibrio precario con la propria sparizione.
Laddove si ricrea un universo definito, dove eroe e destino siano soltanto “eroe e destino” inconsapevoli del proprio trovarsi in una dimensione paradossale in cui la loro esistenza viene dopo la loro fine e dopo la coscienza della loro impossibilità; in una dimensione insomma in cui la loro possibilità non sia fondata sull’ironia (solidale, come diceva Bacthin “piena solidarietà con la parola parodiata”); allora eroe e destino scadono a personaggi e schemi, emblemi di una psicologia convenzionale che non può avere la forza della narrazione che “ispira” l’azione. Perché lungi dall’indicare nel mondo il trionfo del “falso” ne rappresenta la conciliazione, l’accettazione sotto forma di intrattenimento, dove anche i massimi problemi e la realtà stessa decadono a pura convenzionalità (“ornamenti dell’oscurità”).
Quello che sto cercando di dire, è che il discorso più volte emerso (ad esempio nel saggio di Girolamo de Michele su Carmilla), che continua ad assegnare al distacco e alla consapevolezza in letteratura l’oblio della “realtà” e della possibilità di agire su di essa, mentre indica appunto nel ritorno alla realtà e al “prendersi sul serio” la via verso una nuova etica del narrare, dovrebbe tenere conto del fatto che tale “ritorno alla realtà” è possibile soltanto attraverso l’amara accettazione della necessità ineluttabile proprio del distacco e della consapevolezza della scomparsa della pensabilità di un senso unificatore.
Il ritorno alla realtà intesa come realtà “là fuori”, “realtà vera, al di fuori delle mediazioni della letteratura”, mi sembra purtroppo non poter essere che una sorta di nuovo impressionismo, il via libera al flusso di una nuova mitologia, ma non naturale e spontanea, “genuina”, semmai “tecnicizzata”, imposta da quel “loro” che incombe nelle opere di Beckett, perché la realtà là fuori è sempre il “falso” che non si denuncia come tale, ma in se stesso accoglie e oblia la coscienza che avrebbe dovuto illuminarlo criticamente.
Achille
Etichette: Resaca

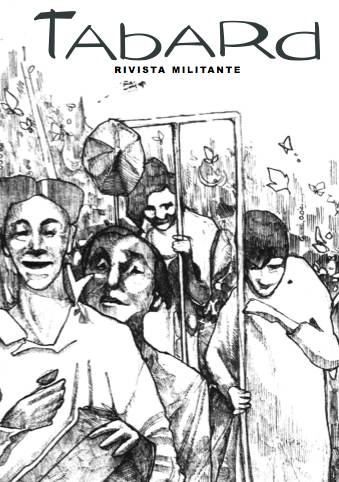


12 Commenti:
Nella mia ignoranza letteraria, mi è piaciuto molto il post di Achille, in particolare il passaggio sulla realtà del NIE "che purtroppo non" può "essere che una sorta di nuovo impressionismo". Mi è così saltato in testa che sull'eterno problema del rapporto tra le forme artistiche e la realtà, e quindi sul tentativo di traduzione mimetica del reale stesso, potrebbe essere interessante rispolverare alcune delle vecchie riflessioni di Erwin Panofsky ne "La prospettiva come forma simbolica". Lo so che potrei passare per matto, ma vi garantisco che le riflessioni di Panofsky sulla temperie culturale intorno alla formulazione della prospettiva albertiana quattrocentesca, potrebbe fornire alcuni strumenti utili per la vostra riflessione sulla prassi realistico-documentaria /epica dei testi citati. Ovviamente molti di voi avranno letto quel libro, pietra miliare della storiografia artistica, che si occupa del concetto di prospettiva come "momento stilistico", “artificio razionale umano”, appunto “forma simbolica”, (interessante in tal caso la querelle di Achille sull’opposizione allegorico/simbolico ) che professa la ricostruzione di una realtà spaziale attraverso precise regole matematiche. Un sofisticato processo razionale che permette che il presunto universo visibile possa essere imbrigliato in griglie geometrico-logiche e riportato su una superficie, l’illusione umana di catturare il reale, descriverlo, ordinarlo, documentarlo. La rappresentazione prospettica quindi come “briglia e timone della pittura”, focalizzata in precise parentesi storiche, nell’illusione che quel tipo di rappresentazione sia la più reale possibile. Come sapete la storia dell’arte è andata poi per altre, altrettanto realistiche, strade. Spero di non essere stato troppo invadente. Ciao. Paolo
Achille, già che mi citi, permettimi alcune precisazioni. Prima di tutto, lungi da me l'idea che sia riproponibile o meritevole di ricerca un "senso unificatore". Su carmilla ho più volte pubblicato testi (ai quali ti rimando, se avrai voglia e pazienza di leggerli) nei quali ho difeso un relativismo radicale (nel senso di W. James, Deleuze e Calvino), e che evito di chiamare nichilismo solo per evitare fraintendimenti. Conseguenza secondaria di alcuni di questi articoli è qualche insulto dalle pagine dell'Avvenire (e da qualche insulsa critica avversa a Calvino), che peraltro mi appunto a mo' di medaglia. Un rilievo che potrei farti è che questa accettazione per me non è amara, ma gioiosa. In tutto quello che ho scritto (anche, spero, come romanziere) non c'è l'idea che la realtà sia "una", né che "stia là fuori". La mia critica a un certo esito del postmoderno, che coincide col relativismo deresponsabilizzante alla Rorty, o a certe visione beatamente estatiche della post-modernità (nichilismo passivo, direbbe Nietzsche) è che anche quella della fine delle ideologia è un'ideologia, e un pensiero unico. Proprio perché la realtà va creata, è un processo in divenire nel quale il senso va piantato dentro, scrivere e descrivere la realtà è un'assunzione di responsabilità. Se questo non era chiaro nel mio intervento, me ne scuso, e faccio tesoro per un prossimo intervento proprio sul "realismo".
*kobra: quello che ti è venuto in mente non mi sembra affatto fuori luogo, visto che parte delle mie riflessioni tenevano conto di una polemica "avanguardistica" del giovane lukacs (intorno agli anni 10), proprio nel campo della pittura, contro un "impressionismo" inteso come positivistica passività nei confronti del reale.
*Girolamo D. M.: in effetti ho sbagliato nel citarti come esempio di una volontà di irriflessa aderenza al reale. Purtroppo c'è il solito problema degli equivoci sull'uso dei termini legati al postmoderno. Ho appena riletto il tuo articolo e devo darti atto che affronti la questione con tutt'altra profondità: nella mia testa si erano sommate più letture degli ultimi giorni, e ho sovrapposto alcune tue affermazioni con altre che c'entravano poco con quello che hai detto.
Poi visto che me l'hai fatto notare, vorrei ritrattare quell'"amara accettazione", che non può che tradire nostalgie assolutistiche. in effetti la gioia viene sostituita dall'amarezza quando zarathustrianamente ci si abbandona alla tristezza nell'ascoltare la voce dell'indovino... ieri devo avere attraversato uno di questi momenti, certo a casua pensiero dell'approssimarsi di una nuova settimana lavorativa...
Achille, la colpa è solo parzialmente tua. La parola "postmoderno" significa ormai talmente tante cose, di segno persino opposto, ed è scivolosa come una saponetta sotto la doccia. Ad esempio, io non la userei mai come emblema del passo di Nietzsche «non ci sono fatti, ma solo interpretazioni», come invece fanno disinvoltamente Luperini e Cortellessa: una cosa è il postmoderno, un'altra il nichilismo. L'uso disinvolto e impreciso delle parole è uno dei tratti caratteristici della crisi culturale che abbiamo alle spalle e tra i piedi: e che Calvino aveva visto per primo, quando nello zainetto delle parole da portare nel terzo millennio mise anche l'esattezza.
"ho difeso un relativismo radicale (nel senso di W. James, Deleuze e Calvino), e che evito di chiamare nichilismo solo per evitare fraintendimenti. Conseguenza secondaria di alcuni di questi articoli è qualche insulto dalle pagine dell'Avvenire (e da qualche insulsa critica avversa a Calvino), che peraltro mi appunto a mo' di medaglia. Un rilievo che potrei farti è che questa accettazione per me non è amara, ma gioiosa."
Caro Girolamo De Michele, non so se tu abbia mai letto la nostra rivista...sono posizioni totalmente tabardiane...
agli altri:...scusate ma sarò latitante ancora per un po'...
Anzi: rileggendo degli appunti per una tesi che prima o poi spero che mi metterò a scrivere, ve li riporto.
Prima una citazione da Brooks, Trame. Poi quello che segue, mio, si riferisce a Los detectives salvajes di Bolanho, ma penso si possa traslare in generale a una teoria della narrazione che cerca di inglobare tempo e contraddizione (mi ricollego anche al post su Stella del mattino)...sarà lungo, dunque, questo commento:
Brooks (e ci si riferisce al saggio di Jacobson su metonimia/metafora... allegoria/simbolo?):
"Il racconto agisce come una metafora nella sua ricerca di somiglianze, in quanto pone in rapporto reciproco azioni diverse, le combina grazie al rilevamento di tali motici simili, e le inserisce in un intreccio comune, il che implica il rifiuto di tutti gli incidenti o situazioni meramente contingenti (o inassimilabili). La trama è dunque l’azione strutturata in unità conchiuse e leggibili; deve così ricorrere alla metafora come tropo delle accennate relazioni di reciprocità, e deve essere metaforico nella misura in cui aspira a essere totalizzante. Eppure è chiaro che la figura chiave della narrativa è in un certo senso non la metafora ma la metonimia, figura della contiguità e della combinazione, delle relazioni sintagmatiche.”
Attraverso catene metonimiche la narrazione tende verso la totalizzazione e l’assolutizzazione metaforica. La chiusura a cui è condannata ogni narrazione dischiude l’unità del senso. “In realtà è dal finale che si è cominciato” (Sartre). Nel “facile” taglio operato dalla struttura del romanzo di Bolanho possiamo intravedere uno spostamento che non è semplice dislocazione dei tempi della narrazione. Il finale del romanzo ci spinge a non chiuderci in una metafora di senso (nemmeno quella, facile, dell’assenza di senso unitario). Ci spinge, invece, a riiniziare a “divertirci”, rileggendo la contingenza metonimica, cioè riprendendo tutti quegli elementi che nella lettura avevamo tralasciati perché inassimilabili e inservibili per la nostra ricerca di lettori-detective. Rileggere la contingenza, relazionarla, non cercare la metafora, ma seguire “un” possibile (e sono, borgesianamente molti possibili) percorso metonimico attraverso le micronarrazioni, come un “lector macho” (lettore attivo...secondo la definizione rinnegata da Cortazar).
...penso che l’opposizione metonimia/metafora sia molto interessante da sviluppare. Spero sia stato utile e comprensibile questo commento, al di là del romanzo di Bolanho.
...ora la partita...
Amici/compagni/concittadini tabardiani: la rivista l'ho scoperta nel corso del dibattito sul NIE, e ne ho approfittato per recuperare qualche lettura precedente, con molto interesse. A partire da indubbie assonanze e/o convergenze. Continuerò a seguirvi, e per il momento complimenti per la rivista: sprizza voglia di vivere in un campo (quello della critica letteraria) dove per bene che vada c'è odore di gerani morti.
*eug: interessante questa opposizione metonimia/metafora, soprattutto credo che l'esemplificazione che ne fai per i detective sia molto appropriata. anche all'interno dei singoli resoconti/deposizioni che costruiscono il romanzo, credo la struttura metaforica non riesca mai a chiudersi/completarsi, proprio a causa delle figure di ulises e arturo, che sono come fantasmi in cui i moltissimi personaggi, di volta in volta protagonisti, sono costretti a specchiarsi e guardare la loro estrema possibilità, che è poi quello che buca "la storia" impedendo ai vari cerchi di chiudersi, e perfino di decidere di rimanere aperti, come nei disegni di cesarea... vabbè, il discorso si allungherebbe ora, ma sarebbe molto bello iniziare una discussione sui detective qui sul blog, visto che non l'abbiamo ancora fatta... a proposito, tabardiani, ma la mia copia dei detective chi ce l'ha?
*girolamo d. m.:grazie per i complimenti, aspettiamo il tuo intervento sul realismo!
caro achille...meno male che è appopriata dato che ci ho speso un sacco di pagine di appunti che confluiranno nella tesi...su questa questione dei personaggi che si specchiano su ulises e arturo ne parlammo una volta a casa tua...io t'offrii il risvolto della medaglia...
dai, apriamo questa discussione così mi fate parte del lavoro...
direi a settembre, comunque... sono assediato da esami da tutte le parti in questi giorni... (sabato me voy a madrid così stacco...)
la tua copia ce l'ha mimmo, colpevolmente sempre nello stesso posto della libreria... ancora non toccata
mmm... qual era il risvolto della medaglia? purtroppo per molto tempo non ci ho più riflettuto e ora non me lo ricordo. Però più passa il tempo più quel romanzo mi sembra immenso.. è incredibile, capita di trovarsi a ripensarci nelle situazioni più diverse, credo proprio perché bolano ha reso U. e A. il punto estremo in cui moltissimi luoghi "comuni" della vita vanno a infrangersi, descostruirsi, e poi necessitano di nuova riflessione/ricomposizione, anche se provvisoria (quello che tu hai chiamato "ricominciare a divertirsi", ricominciare a seguire nuovi percorsi ricombinando gli elementi...)
beh, comunque visto che sei in partenza per madrid, abbi almeno il buon gusto non lamentarti degli esami!
leggere l'intero blog, pretty good
La ringrazio per intiresnuyu iformatsiyu
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page