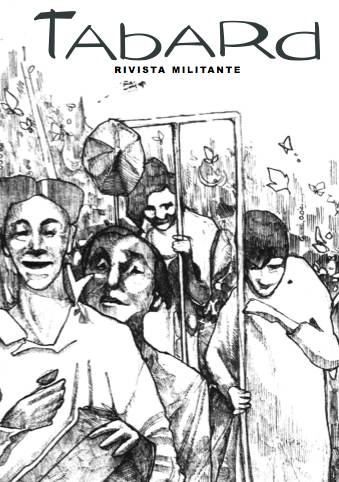Morta la disciplina, se ne sarebbe dovuta fare un’altra (tutto qua)

È un problema della mia ‘costellazione’, oppure é un riflesso dei tempi, oppure semplicemente c’est la vie, se leggo Antonio Scurati, su Tuttolibri, e invece di pensare ai più scontati riferimenti culturali per parlare della comparatistica oggi (Gayatri C. Spivak, con Morte di una disciplina, oppure, mettiamo, T. Todorov con La letteratura in pericolo) riesco soltanto a pensare a Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte, per la precisione, che cammina pensoso per le quinte di “Veline” e consola una delle ragazze eliminate. Nell’immagine successiva, Giuseppe Conte che lo scrive, con penna ferma e intenzionalmente “autoironica”, per il “Giornale”.
(E poi Andrea Cortellessa che per tutto questo fornisce un’interpretazione plausibilissima, in Parola Plurale.)
Il che é come dire che non mi rimane quasi niente delle considerazioni di Scurati e che gradualmente perdo ogni empatia che avevo stabilito con il suo incipit, davvero fulminante – un effetto stilistico garantito, del resto, a chi si muove costantemente in cerca di definizioni epocali (vedi alla voce ‘Inesperienza’):
“Al giro del nuovo millennio si discusse molto nelle università italiane della necessità di un nuovo canone letterario. Si capì, finalmente, che lì dove andavamo il canone nazionale tradizionale non ci avrebbe seguiti. Si discusse molto di un canone aperto, globale, di una riforma dell’insegnamento universitario nell’ottica della comparatistica interlinguistica, interdisciplinare. Si discusse, poi non se ne fece niente. Il canone evaporò, il matrimonio tra l’istituzione letteraria e l’educazione delle nuove generazioni non si fece. E, se si fece, non venne consumato. Rimase il mercato.”
Quella di Scurati è senza dubbio una scrittura tranchante, abile nell’individuare la minaccia costante del romanzo globalizzato rispetto al romanzo globale (e, in senso lato, dell’umanesimo globalizzato, che attinge al supermercato della multiculturalità, direbbe uno Žižek, ma non sa capirne le dinamiche, né situarvisi veramente, rispetto all’umanesimo planetario invocato da Spivak) e la crisi del matrimonio tra l’istituzione letteraria e l’educazione delle nuove generazioni.
L’esempio fornito da Scurati di questa situazione culturale é la disperazione dei giovani laureati, soprattutto se nelle deprecabili materie umanistiche – i quali, messi di botto (o di nuovo) di fronte alla precarietà, tornano a ricevimento dai professori con i quali hanno lavorato per la tesi con questa domanda che preme loro in gola:
“E adesso... che faccio adesso? Mi rendo conto che non sono affari suoi... Ma che ne devo fare della mia vita?”
Un esempio che, anche per il sottoscritto, suona di una verosimiglianza lacerante.
Se, però, l’immagine di Giuseppe Conte presidente di giuria della finale di “Veline” incombe sulle parole del Nostro è anche perché, probabilmente, le argomentazioni a supporto – che saranno presentate più compiutamente in un dibattito pubblico con Filippo La Porta e Tiziano Scarpa, a Palermo, il prossimo weekend, nel contesto del premio MondelloGiovani – non collimano con questa ouverture brillante, ben scritta e criticamente arguta.
Non convince, per esempio, l’attacco, peraltro implicito, portato al pensiero debole che si è insinuato nella comparatistica, cercando di riaprire un canone in precedenza chiuso e asfittico, e nell’insegnamento universitario in genere.
Può darsi, sì, che aver tentato di decostruire, o semplicemente di rielaborare e rinnovare, il canone abbia esposto i suoi elementi (ora dispersi, ora labilmente collegati in temporanee ‘costellazioni’ anti-essenzialiste) alle esigenze di mercato – creando fenomeni editoriali come la letteratura indiana in lingua inglese, o certo realismo magico sudamericano di ritorno, ma non sostanziandone la lettura con un’adeguata formazione e informazione sul background culturale, storico e politico sulla quale queste opere si stagliano.
Può essere, e anch’io spesso mi ripeto la formula d’esorcismo “debole, ma non coglione”, che può aiutare ad andare avanti, però... Però dietro le parole di Scurati, qui, spunta l’ultimo Todorov e tutto un filone critico d’estrema attualità, che pur di gettare a mare le storture del ‘68, getta a mare anche strutturalismo-e-seguenti – rei, sostanzialmente, ‘di averci complicato le cose, a tutti’...
Ebbene, la letteratura non sta, o non sta solo, correndo questo pericolo, eminentemente pedagogico.
Il canone, per esempio, non è ‘evaporato’. Non ci sono proposte ‘forti’, questo è vero, ma la discussione sul da farsi è fitta, forse fin troppo. La proposta di un nuovo “canone della giovinezza”, per contro, cozza contro alcuni semplici dati di realtà: per riscrivere il canone, bisogna averlo letto, e l’attuale insegnamento scolastico trova difficile, per mille motivi, farlo leggere.
Scurati non mi persuade, quindi, perché manca completamente – almeno in questo estratto pubblicato per ttl – di uno sguardo anche minimo sullo smantellamento dell’università. Operazione che non è imputabile solo a don, pardon, alla signora Gelmini, ma che risale alle mefistofeliche imprese di Ortensio Zecchino, Luigi Berlinguer & Co., ormai vecchie di un decennio. Se i giovani laureati cadono senza rete nella precarietà sociale, è anche perché sono passati per un esamificio, non per l’università, perché dentro l’università non ci sono prospettive serie né di lavoro di ricerca, perché l’università non migliora la condizione di vita di chi la fa, rispetto ai genitori.
Nozionismo e immobilismo sociale, insomma. E certe aule assomigliano a grandi, immensi parcheggi. Manca la scritta (che potrebbe essere benissimo ‘Coop’.)
Se, da un lato, mi attrae l’affondo contro la precarietà sociale, non capisco il romanticismo di riflusso che ne consegue, romanticismo dal quale Scurati vorrebbe mettersi al riparo, evidenziandolo con distanza critica e ironia, ma al quale poi finisce per soggiacere. Scrive, infatti, di una precarietà che costringe i giovani alla “prosaicità” della loro “datità sociale”, nel quale non si ha bisogno della “precarietà esistenziale”, in qualche modo “più poetica”, che si insegna attraverso un’adeguata formazione e informazione letteraria.
Dall’alto della stessa datità, non vedo perché precarietà sociale e esistenziale non possano andare di pari passo, perché dare degli ignoranti a laureati che magari lo sono – vedi la marea di giornalisti, dentisti e avvocati che non prendono un congiuntivo uno – ma ai quali non si vorrà negare un’analisi lucida della loro condizione. E un poco di poesia, almeno.
Che abbiano o no un canone letterario (italiano) della giovinezza come riferimento.
Dulcis in fundo, Scurati ci propina la rievocazione elegiaca del professore che allo studente in disperata ricerca d’aiuto offre un libro gualcito estraendolo dal cassetto:
“Té, leggi questo. É tutto qui dentro”
Grazie dell’aiuto. (“Té”...?!)
Nella speranza che, conoscendo il professore, non si tratti di un (suo) romanzo storico.
Comunque, si diceva di Giuseppe Conte.
Giuseppe Conte.
Nessuno vuole negare il diritto di una persona ad avere “un’ora di divertimento (sic) fuori dal suo solito mondo”, obbligando l’intellettuale alla sobrietà monastica cui si riducevano, ridicolmente, certi paladini del veteromarxismo, alcuni decenni orsono.
Però, fatelo; non ditelo, non giustificatelo. Quello che si accennava per il critico Steiner valga anche per il poeta-presidente di giuria Giuseppe Conte.
C’è una grande urgenza di sdoganamento, in giro (vedi alla voce, neologica, ‘non-antifascismo’), e il poeta sdoganato sul palco di ‘Veline’, come a suo tempo il sedicente ‘poeta del Grande Fratello’, esprimono una gran voglia di sdoganare l’ignoranza in televisione (facendola legittimare da un personaggio della Cultura, meglio se un Poeta), dopo esserci riusciti, significativamente (ultime elezioni: sul 7-8%...) nella politica.
Una eccessiva “autoironia” potrebbe dare il vero colpo finale alla coppia istruzione letteraria-educazione delle nuove generazioni.
Incredibile, per certe cose a volte il liberissimo mercato da solo non basta.
Lorenzo Mari
Etichette: Resaca
Leggi tutto il post