Pamuk, la letteratura, l'occidente
Ora, questo libretto pare fornire alcune risposte, non esaustive, ma utili a sondare un certo terreno, alle nostre domande di domenica.
La prima risposta è che, fuori dall’Europa, dove la marginalità economica e politica ha fatto sentire i suoi nefasti effetti, si guarda alla letteratura “occidentale” con quel misto di sudditanza e timore proprio delle “periferie” dell’Impero. Questo fa sì che Pamuk, figlio della media borghesia di Istanbul, parli della grande letteratura incarnandola in nomi noti e comuni (si va da Kafka a Tolstoj, da Mann a Faulkner….) e citi in tralice L’arte del romanzo di Kundera, da cui riprende, senza richiamarlo, il sintagma utile a descrivere la sua attività di narratore. Dunque il lettore europeo dei romanzi di Pamuk si trova nella curiosa posizione di delibare una narrativa le cui strutture gli sono familiari, innestata su “descrizioni” (in senso strettamente narratologico) “esotiche”: i luoghi, le figure, i personaggi. Qui certo non si fa quello che Said ha già decostruito: niente “orientalismo” alla Baudelaire o alla Flaubert. Ci mancherebbe: è solo che pare chiaro come la contaminazione possa avvenire a livelli narratologici caratterizzanti e non strutturali. Forse, per leggere letteratura non europeizzante, a questo punto, non restano che i magnifici canti orali delle tribù africane o asiatiche. Ma il nostro orizzonte d’attesa forse ce ne impedirebbe la comprensione (ammesso si trovi chi traduce!).
La seconda risposta è che per Pamuk, e per tanti altri autori non europei, la letteratura è vissuta come religio, con quella nativa, sorgiva fiducia nella trasmissione della parola che nei nostri perimetri è oramai invece solo agente degli aspetti “finzionali”.
«Credo nella letteratura […] più di quanto io creda in qualunque altra cosa», dice Pamuk. Ricorda Bo, imbiancato e pedante, ma idealmente impegnato. La speranza è che questa vena di fides si concreti in una forma di osmosi fertile per i nostri dubbi e la nostra incapacità di incarnare nei testi la vecchia mimesis platonica. Chi ha letto lo Scurati de La letteratura dell’inesperienza capirà cosa voglio dire: c’è bisogno di tornare a scrivere la realtà partendo dall’esperienza della realtà. E per questo c’è bisogno di identità concentriche.
Credere nella letteratura significa insomma, per una neomarxista quale sono, credere ancora che la letteratura possa essere una forma di conoscenza (e quindi di critica) della realtà, e possa incarnare di nuovo il ruolo che aveva per Ungaretti: «il mondo, l’umanità, la propria persona». La sola speranza è già consolante.
Eleonora (elpinzu@tin.it)
Etichette: Resaca

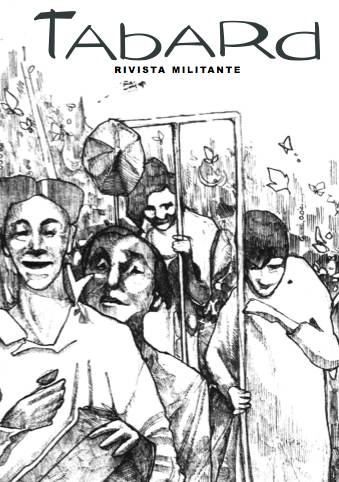


0 Commenti:
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page