Ma qual è il bene assoluto?
 Poche notti fa ho fatto un sogno. Mi trovavo nel mezzo di una disquisizione intorno alla natura del bene assoluto, e chiaramente le posizioni dei partecipanti al dibattito erano marcate da nette e profonde differenze. Animatori di questo appassionato dialogo erano padre Bisceglia, il noto prete cosentino arrestato per violenza sessuale su una suora, il neo ministro Rosy Bindi, un tifoso della Juventus e una coppia di fidanzati. L’infuocato dibattito vedeva per lungo tempo opposti padre Bisceglia e la Bindi. Il prete, sostenitore dell’identificazione tra il bene assoluto e Dio (pur non disdegnando di evidenziare l’importanza delle suore), aveva molto da ridire con la Bindi, che dal suo canto tendeva invece a ipostatizzare il valore della famiglia. Nell’ambito del serrato confronto dialettico il religioso ha avuto un unico tentennamento di fronte ad alcune avances del neo ministro, subito però respinte in un impeto di strenuo volontarismo. Partecipi al dibattito, ma un po’ più in disparte, c’erano poi il tifoso della Juve, secondo cui il bene assoluto doveva essere identificato con il cellulare di Moggi, e la coppia di fidanzati, sostenitori dei rapporti liberi ed aperti, che parlavano del bene nei termini della «capacità del proprio partner di lasciare all’altro la possibilità di nuove relazioni». Mentre quasi mi convincevo della validità di questa teoria, sono purtroppo stato svegliato da una telefonata, in cui mi si chiedeva di intervenire nel dibattito in corso sulla militanza con un mio post.
Poche notti fa ho fatto un sogno. Mi trovavo nel mezzo di una disquisizione intorno alla natura del bene assoluto, e chiaramente le posizioni dei partecipanti al dibattito erano marcate da nette e profonde differenze. Animatori di questo appassionato dialogo erano padre Bisceglia, il noto prete cosentino arrestato per violenza sessuale su una suora, il neo ministro Rosy Bindi, un tifoso della Juventus e una coppia di fidanzati. L’infuocato dibattito vedeva per lungo tempo opposti padre Bisceglia e la Bindi. Il prete, sostenitore dell’identificazione tra il bene assoluto e Dio (pur non disdegnando di evidenziare l’importanza delle suore), aveva molto da ridire con la Bindi, che dal suo canto tendeva invece a ipostatizzare il valore della famiglia. Nell’ambito del serrato confronto dialettico il religioso ha avuto un unico tentennamento di fronte ad alcune avances del neo ministro, subito però respinte in un impeto di strenuo volontarismo. Partecipi al dibattito, ma un po’ più in disparte, c’erano poi il tifoso della Juve, secondo cui il bene assoluto doveva essere identificato con il cellulare di Moggi, e la coppia di fidanzati, sostenitori dei rapporti liberi ed aperti, che parlavano del bene nei termini della «capacità del proprio partner di lasciare all’altro la possibilità di nuove relazioni». Mentre quasi mi convincevo della validità di questa teoria, sono purtroppo stato svegliato da una telefonata, in cui mi si chiedeva di intervenire nel dibattito in corso sulla militanza con un mio post.E allora eccomi qua, a discutere di quale sia la forma migliore di militanza. Per quanto riguarda l’idea di una «ricaduta nel dibattito cittadino sulla cultura», è chiaro che Tabard nasce esattamente con questo spirito. Penso alle numerose conversazioni che si sono susseguite prima di partire con questa attività editoriale, e mi sembra di ricordare che nessuno di noi prescindesse dall’idea di portare avanti un discorso soprattutto politico. Al riguardo, mi rallegra pensare che Fernando Bollino, nel suo editoriale su Studi di estetica, abbia messo in evidenza proprio questo aspetto della nostra rivista. Il problema, a questo punto, è legato alla prassi. Personalmente trovo doveroso pensare di indirizzare questa nostra azione verso la creazione di nuovi spazi di intervento sul sociale (e quando parlo di “creare” nuovi spazi intendo per l’appunto la necessità di rifiutare una semplice dinamica di riappropriazione, che è alla base invece delle rivendicazioni di numerosi movimenti). Tracciare però un programma dettagliato che identifichi i passaggi di realizzazione di questo progetto è cosa chiaramente difficile, e forse neanche funzionale. D’altronde l’impostazione eterodossa e relativista di questa rivista sarebbe poi in contrasto anche con un simile presupposto.
Dunque cosa fare? Innanzitutto credo che il lavoro sinora svolto sia già un chiaro segno della volontà di agire socialmente che ci ha mosso, e sono contento che quanti sono venuti in contatto con la rivista ci stimolino a non fermarci, a non cadere in uno sterile sentimento di appagamento che porterebbe alla ripetizione. Penso che, prendendo spunto dalle parole di Andrea, sia giusto a questo punto pensare con maggiore attenzione alle realtà sociali cittadine e provinciali, andare ad affondare lo sguardo nel loro tessuto, entrare (o meglio tornare) in una dinamica di partecipazione anche con quei luoghi (per molti di noi differenti e sparpagliati per il paese), la cui problematicità è forse tra le cause prime che hanno determinato a partire dal passato un bisogno di azione.
Quanto detto potrebbe forse apparire scontato, ma chiaramente, affrontando il discorso della prassi, di una prassi che soprattutto non vuole avere una progettualità forte, appare palese la difficoltà di dire una parola definitiva. Piuttosto, se una caratteristica deve essere assunta dalla nostra “parola”, credo che questa debba essere la capacità di parlare volendo arrivare al profondo, a infilare la mano nella pancia, nelle viscere, affinché questo strumento che noi usiamo diventi responsabile, conseguenza di una scelta di engagement. Concludendo, per dirla con la voce di Roberto Saviano, presa a prestito dal suo bellissimo primo libro Gomorra, il nostro impegno deve consistere nel cercare di erodere «dalle cave della sintassi quella potenza che la parola pubblica, pronunciata chiaramente, poteva ancora concedere, [evitando] l’indolenza intellettuale di chi crede che la parola ormai abbia esaurito ogni sua risorsa che risulta capace solo di riempire gli spazi tra un timpano e l’altro. La parola come concretezza, materia aggregata di atomi per intervenire nei meccanismi delle cose, come malta per costruire, come punta di piccone […] una parola necessaria come secchiata d’acqua sugli sguardi imbrattati […]. La parola diviene un urlo. Controllato e lanciato acuto e alto contro un vetro blindato: con la volontà di farlo esplodere».
Vittorio Martone
Etichette: Bâtard

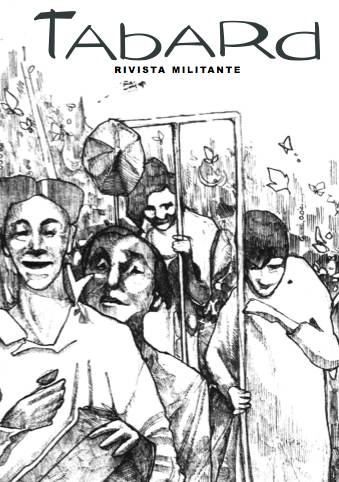


1 Commenti:
carissimo Vittorio, parto dall'ultimo sintagma che citi: "con la volontà di farlo esplodere". è ormai chiaro che è la volontà quel collante che tiene insieme pensiero ed azione, non la stretta coerenza. la logica, l'analisi sarà sempre in grado di smontare (prima o poi) quello che avremo fatto. Sì, ciò in cui crediamo sono illusioni, ma se queste ilusioni possono contribuire a costruire una società stretta in grado di ridare dei costumi a questo maledetto paese (e non solo deteriori abitudini), allora ci sto a nutrirle. E' il discorso, tra il lucido e il disperato,che fa quell'onanista di Leopardi nel suo "Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani" (1824),dove si dimostra tutt'altro che quell'inetto che la vulgata ha tramandato (tra parentesi: siamo ancora disposti ad acarezzare come un vecchio micio il mito dell'inetto, ora che abbiamo fondato una rivsta di analisi e critica che ha tra i suoi ispiratori "Sesto Empirico, Socrate, Lucrezio, Valla, Montaigne..."?).
Insomma il problema è sempre quello: mettere temporanemante in disparte l'Umanesimo di Petrarca-Valla (quello della supremazia del pensiero sulla mani, sull'azione) e far nostro quello di (Bruni-Salutati)-Alberti,di una potenzialmente dirompente parità e circolarità tra pensiero e mani (siamo uomini perché siamo sapiens ma anche perché abbiamo il pollice opponibile alle altre dita, se no eravamo ancora lì a farci i seghini sugli alberi).
Insomma, la verifica al pensiero non la si trova nel pensiero stesso (tautologia), ma nella prassi. e questa verifica deve essere quotidiana, solo così si può correggere il tiro, spostare continuamente il bersaglio dell'utopia, prima che si costruiscano enormi castelli che crolleranno inesorabilemente al primo soffio di vento.
Con verifica nella realtà intendo che la cultura deve farsi politica culturale, deve creare, deve essere feconda (deve creare biblioteche, case del popolo, case della cultura, una classe dirigente, etc...). ed assumersi così le responsabilità soggettive - e qui mi rifaccio ai discorsi correnti tra Achille e Mimmo - di esercitare una egemonia
Sevo
Posta un commento
Iscriviti a Commenti sul post [Atom]
<< Home page